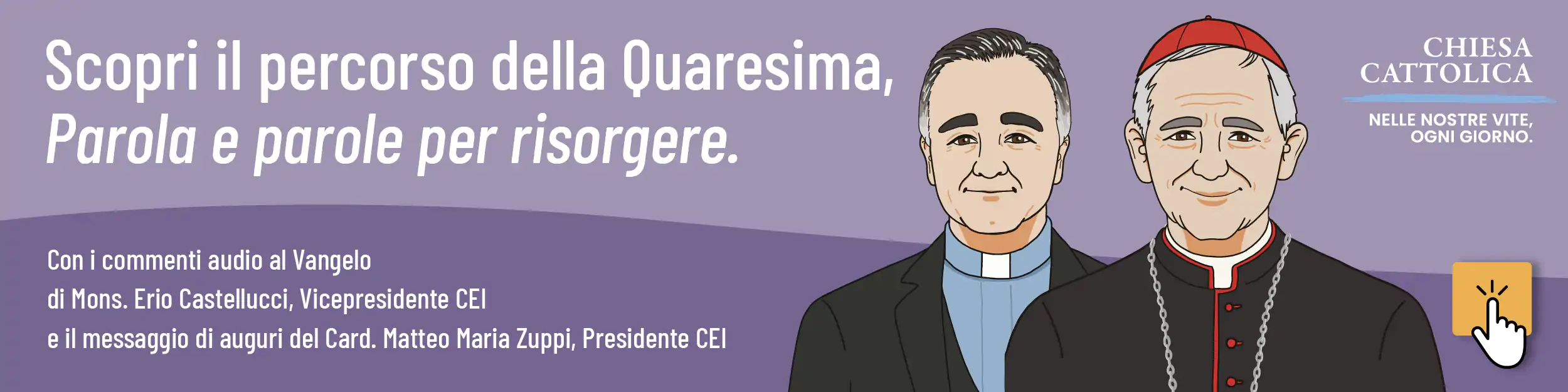Commento al Vangelo
Domenica 31 agosto, commento di don Renato De Zan
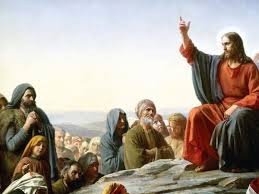
Lc 14,1.7-14
Avvenne che 1 un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo…7 Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 8 «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 9 e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 10 Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 11 Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 12 Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 13 Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14 e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
Il cristiano è chiamato all’umiltà e alla gratuità
Il Testo
1. Lc 14,1.7-14 è un testo chiaramente eclogadico. La Liturgia, infatti ha tolto Lc 14,2-6. Si tratta di un brano che narra la guarigione di un uomo malato di idropisia in giorno di sabato. Naturalmente, Gesù prima di compiere il miracolo chiede ai presenti se sia lecito guarire in giorno di sabato. Di fronte al silenzio Gesù agisce e spiega: “Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?”. La reazione è da incorniciare: “E non potevano rispondere nulla a queste parole”. Questo episodio in qualche modo oscura quanto viene narrato dopo. La Liturgia lo toglie e fa due piccole aggiunte. Il testo della pericope inizia così: “Un sabato si recò a casa di uno dei capi…”. Il testo della formula, invece, ha questo incipit: “Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi…”.
2. La formula liturgica è scandita in quattro unità. Il testo si apre con la presentazione della scena (Lc 14,1) che si svolge in casa di uno dei capi dei farisei. Segue un racconto esemplare per tutti con un invito pressante al senso della modestia (Lc 14,7-10). L’insegnamento si conclude con un detto sapienziale (Lc 14,11): “Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. La quarta unità comprende un secondo racconto esemplare, ma questa volta è personalizzato perché indirizzato al capo dei farisei (Lc 14,12-14): invita chi non può ricambiarti perché la vera ricompensa viene data da Dio.
L’Esegesi
1. Diversamente da noi, Gesù riteneva molto importante il momento conviviale per annunciare il suo vangelo. Ricordiamo velocemente almeno tre momenti conviviali di Gesù, narrati dal vangelo di Luca. Il primo, Lc 5,29-32, offre a Gesù la possibilità di chiarire che “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi”. Nel secondo, Lc 7,36-50, Gesù enuncia un principio fondamentale della morale cristiana: “Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco”. Infine, nel terzo momento, Lc 15,1-32, Gesù manifesta la sconfinata misericordia di Dio (racconti della pecorella smarrita, della moneta perduta e del figliol prodigo). Non dimentichiamo Lc 22,14-38, dove troviamo narrata l’ultima cena in cui Gesù istituisce Sacerdozio ed Eucaristia.
2. Nella Chiesa delle origini c’era un’attenzione particolare all’umiltà e alla gratuità. Significativa è l’esortazione che si trova in 1 Tm 6,17-19: “A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nell’instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera”. Senza umiltà e gratuità non c’è generosità e nemmeno il perdono dei propri peccati (acquisizione della vita eterna).
3. Sappiamo che i farisei ambivano ai primi posti. Lo dice chiaramente Matteo in Mt 23,6: “Si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe”. Lo ripete Marco in Mc 12,28-29: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti”. L’invito all’umiltà non significa un invito all’auto-umiliazione o ad accettare passivamente l’umiliazione che gli altri spesso ci infliggono. L’umiltà cristiana è semplicemente la consapevolezza di ciò che Dio vorrebbe che noi fossimo e di ciò che, invece, in realtà siamo. Non sono, perciò, gli altri in nessun modo la misura della nostra umiltà.
4. La gratuità voluta da Gesù, sebbene illustrata in una azione (invito a chi non può ricompensarti), non è un’azione. È un atteggiamento che imita l’atteggiamento di Gesù. Paolo chiarisce questo aspetto di non facile comprensione in 1 Cor 13,3: “E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità (=agàpe), a nulla mi servirebbe”. La carità non è “dare”, ma “essere”. Lo stesso vale per la gratuità, figlia della carità (= agàpe).
Contesto Celebrativo 1. Il testo eclogadico della prima lettura (Sir 3,17-20.28-29) identifica l’umile (v. 18) con il mite (v. 19). Chi ha queste virtù sarà amato più di un uomo generoso (v.17). All’opposto, il superbo è abitato dalla pianta del male. La Colletta propria non risponde direttamente alle tematiche del Vangelo e della prima lettura. Preferisce la dimensione morale. Nella petizione e nella complementare l’assemblea prega così: “Concedi a noi di onorare la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti”. Si tratta di un atteggiamento degnissimo per il cristiano. Ma non è questo il tema della Liturgia della Parola.