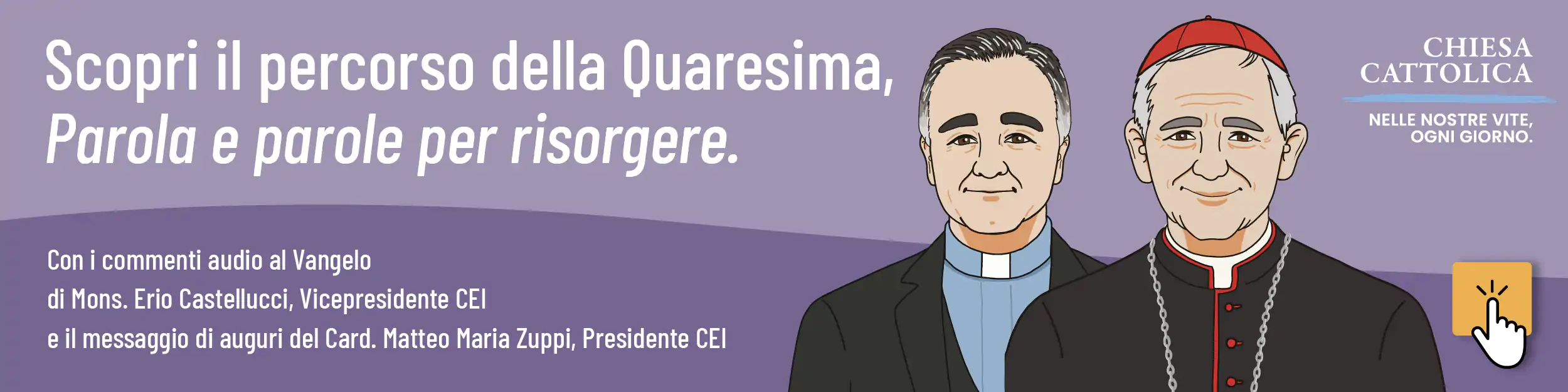Commento al Vangelo
Domenica 5 gennaio, commento di don Renato De Zan

05 Gennaio 2025. 2° dopo Natale
“E il Verbo si fece carne in mezzo a noi”
Gv 1,1-18
1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 2 Egli era, in principio, presso Dio: 3 tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 4 In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 5 la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 6 Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 7 Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 8 Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 9 Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 10 Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 11 Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 12 A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13 i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 15 Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». 16 Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 17 Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 18 Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Il Testo
1. Senz’altro questo inno meraviglioso (Gv 1,1-18) non è nato con il vangelo di Giovanni, ma è stato collocato in un tempo successivo alla composizione. La prova è duplice: il tema del “Logos” non compare più nel quarto vangelo e lo stile dell’inno non è quello della narrazione evangelica. Il testo, a sua volta, è stato arricchito da due tipi di glosse. Il primo tipo annovera glosse (aggiunte) giovannee e riguardano il Battista (vv. 6-7.15), il secondo tipo comprende glosse esplicative (vv. 13.17) perché chiariscono espressioni teologicamente impegnative.
2. La struttura del testo (pericope e formula sono identiche) è variamente interpretata. La più aderente al testo sembra rispondere – senza le glosse – alla divisione in tre strofe irregolari. In Gv 1,1-5 viene presentato il “Logos” presso Dio e il creato (segue la prima glossa giovannea: vv. 6-8). In Gv 1,9-12 troviamo il “Logos” in rapporto al mondo degli uomini e in modo particolare al mondo degli ebrei (segue la glossa esplicativa del v. 13). In Gv 1,14.16.18 il “Logos” è messo in rapporto con la comunità cristiana (“in mezzo a noi”), mentre in Gv 1,15 leggiamo una glossa giovannea e in Gv 1,17, una glossa esplicativa.
L’Esegesi
1. Il Logos è la seconda persona della Trinità che nell’Incarnazione prende il nome di Gesù di Nazaret. Nella prima strofa irregolare (Gv 1,1-5) il Logos viene presentato come Dio (non come “divino”), continuamente rivolto verso il Padre in atteggiamento di intercessione per gli uomini. Da lui prende esistenza l’universo (Dio, in Gen 1,1-2,4a, crea il mondo per mezzo della Parola). Il Logos, infatti è la vita e la luce, che non può essere soffocata dalla cattiveria degli uomini.
2. Nella seconda strofa (Gv 1,9-12) l’inno presenta il Logos come colui che non è stato né riconosciuto né accolto dagli uomini in genere e, in modo particolare, dagli ebrei. A chi lo ha accolto come Logos del Padre, ha offerto la scelta di essere figlio di Dio. Per questo motivo, nella terza strofa (Gv 1,14.16.18) parla la comunità dei figli di Dio che testimonia come dopo l’Incarnazione ha ricevuto ogni grazia dal Logos diventato carne, in modo particolar, il dono della vita e della conoscenza del Padre.
3. Le glosse giovannee sembrano siano state collocate dopo che l’inno era stato posto all’inizio del quarto vangelo e riprende alcune tematiche che sono presenti in Gv 1,19-34. Le glosse esplicative, invece, sono un po’ più delicate da spiegare. Gv 1,13 è accostato al testo dell’inno in modo goffo (in greco la concordanza del pronome relativo è grammaticalmente zoppicante). Spiega, però, che essere figli di Dio non proviene da diritti di nascita, ma per una scelta che accoglie il dono di Dio. Gv 1,15 chiarisce l’espressione finale di Gv 1,16 (“abbiamo ricevuto e grazia sua grazia”). La prima grazia è stata la legge di Mosè, superata e completata dalla grazia e dalla verità. Si tratta di una endiadi (la grazia della verità), che equivale a dire “il dono della fedeltà totale del Padre verso l’umanità, manifestatasi in tutto il mistero di Cristo (parole, opere e Mistero Pasquale).
Il Contesto Liturgico
1. La prima lettura (Sir 24,1-4.8-12) fa parlare la Sapienza di Dio che possiede le stesse caratteristiche del Logos. La Sapienza è Parola (“Sono uscita dalla bocca dell’Altissimo”.) come Cristo è la Parola (Gv 1,1: “In principio era il Verbo….”). La Sapienza è “inviata tra gli uomini” come il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). La Sapienza pianta la tenda tra gli uomini e il Verbo “piantò la tenda (cf il greco eskènosen ) in mezzo a noi” (Gv 1,14). La Sapienza dà culto a Dio (“ho officiato nella tenda santa davanti a Lui”) e il Verbo si trova in perpetuo atteggiamento di intercessione presso Dio (e il Verbo era “pros ton Theòn”) Con l’associazione di Sir 24 con Gv 1 la Liturgia proclama quanto Paolo dice in 1 Cor 1,24.30: Cristo, “diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione”, è “potenza di Dio e sapienza di Dio”.
2. Il testo eclogadico della seconda lettura (Ef 1,3-6.15-18) illustra due realtà grandi della fede: la scelta gratuita e amorevole che Dio ha fatto nei confronti di ciascuno di noi “prima della creazione del mondo” perché siamo “santi e immacolati”; il dono dello “spirito di sapienza e di rivelazione” e dell’illuminazione “degli occhi della…..mente” perché possiamo avere “una più profonda conoscenza di lui”, “comprendere a quale speranza” Dio ci ha chiamato e “comprendere quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi” per noi.