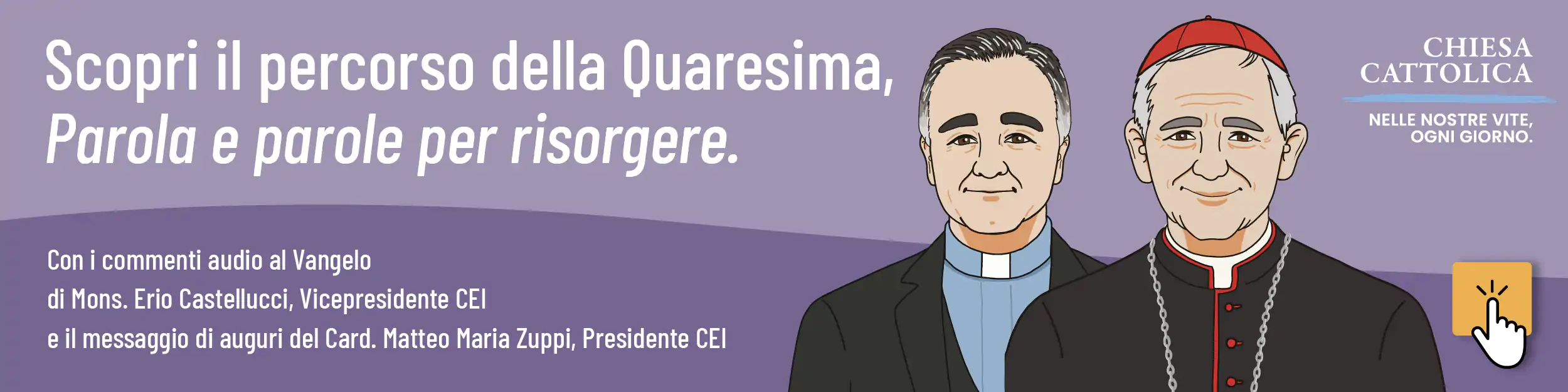Commento al Vangelo
Domenica 12 ottobre, commento di don Renato De Zan

Lc 17,11-19
11 Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 12 Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 13 e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». 14 Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. 15 Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16 e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17 Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 18 Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». 19 E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Si prostrò davanti a Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano
Il Testo
1. Il viaggio intrapreso da Gesù dalla Galilea (Lc 9,51) verso Gerusalemme (Lc 19,28) sta lentamente concludendosi. Il testo evangelico corrisponde perfettamente alla formula evangelica liturgica. Non c’è stato nessun ritocco della Liturgia. Il brano è scandito in tre momenti narrativi. Nel primo momento troviamo la presentazione della scena: Gesù sta avvicinandosi al suo mistero di morte e resurrezione (Lc 17,11). Il secondo (Lc 11,17,12-16) narra la guarigione dei dieci lebbrosi e il ritorno del lebbroso samaritano per ringraziare Gesù. Il terzo momento (Lc 17,17-19) racchiude una riflessione sapienziale del Maestro e una considerazione fondamentale sul potere della fede.
2. Il testo della formula evangelica (Lc 17,11-19) procede, a livello stilistico, con il criterio della rastremazione: da un orizzonte ampio (Samaria, Galilea), il narratore focalizza l’azione in un orizzonte più stretto (un villaggio), dal dialogo con dieci persone (i lebbrosi) restringe il campo al dialogo con una persona sola (il samaritano). Sembra che l’obiettivo della narrazione sia quello di costringere il lettore a leggere in profondità il miracolo associato al cammino di Gesù verso Gerusalemme. Bisogna, infatti, ricordare che le parole “guarigione” e “salvezza” si dicono, in greco, con un unico termine. Ciò che Gesù compie nei confronti dell’uomo ammalato è la manifestazione personalizzata dell’opera universale di redenzione che sta per portare a compimento a Gerusalemme. La risposta dell’uomo è la gratitudine per la guarigione-salvezza.
L’Esegesi
1. Sappiamo che i Samaritani, all’epoca di Gesù, non erano ben visti dagli Ebrei, che venivano ripagati con la stessa antipatia. Anche Gesù ne farà le spese (Lc 9,51-56). Questo razzismo non c’è tra i lebbrosi. Accomunati nella sofferenza, riscoprono la condivisione umana della vita. Sono costretti a rispettare le leggi della purità: il lebbroso era un impuro, totalmente invaso dalla morte. Si fermano a distanza, implorano la guarigione. Le prescrizioni del libro del Levitico sono molto dure. Il lebbroso è un impuro e il suo contatto con persone sane, le rende impure. Il lebbroso doveva vivere fuori dell’accampamento (fuori dal villaggio o dalla città), non poteva far parte dell’assemblea liturgica ed era considerato un peccatore. I rabbini dicevano che il lebbroso era un morto che respirava.
2. La guarigione compiuta da Gesù è un miracolo multiforme. È perdono del peccato, è una vera e propria risurrezione, è una restituzione della vita sociale e religiosa. L’azione di Gesù rispetta fino in fondo la legge ebraica e contemporaneamente la supera. Le legge determina i vari comportamenti, compreso quello dei lebbrosi. La legge constata la guarigione del malato. La legge, però, non guarisce, non salva. Solo Cristo salva.
3. Il senso di riconoscenza era presente nell’animo del samaritano guarito dalla lebbra, ma stranamente era assente nei suoi colleghi ebrei, anch’essi guariti dalla lebbra. La guarigione è avvenuta perché il samaritano ha avuto fede, dice Gesù. Anche gli altri nove, però, sono stati guariti. Quale è la differenza fra gli altri nove e il samaritano? Mentre gli altri hanno vincolato la loro fede all’adempimento della legge come realtà più grande, il samaritano ha veicolato la sua fede verso il rapporto personale con il taumaturgo. La fede del samaritano porta l’uomo a Cristo. La fede degli Ebrei li porta alla legge. La fede che lega a Cristo genera riconoscenza, l’altra, no.
Il Contesto celebrativo
1. La gratitudine verso Dio è una esperienza purtroppo molto ridotta nello spirito umano. Se uno facesse una breve indagine nel libro dei salmi, si accorgerebbe che le lamentazioni e le suppliche sono molto più numerose dei salmi di ringraziamento. Per questo motivo la Colletta generale, nella petizione ricorda all’assemblea orante che Dio è “colui che dona la salute del corpo e il vigore dello spirito”. Ne consegue che, nel fine della petizione, l’assemblea invoca: “Affinché, rinnovati dall’incontro con la tua parola, possiamo renderti gloria (= ringraziarti) con la nostra vita”:
2. La prima lettura (2Re 5,14-17) narra l’episodio toccante di Naamàn. All’invito del profeta Elisèo, Naamàn protesta perché dalla sue parti c’era molta più acqua di quanta ce ne fosse nel Giordano. Poi obbedisce e si immerge. Ne esce guarito. La sua riconoscenza non è venale. È piena di fede, magari ancora primitiva. Ma è fede vera: porterà ad Aram quattro sacchi di terra d’Israele per fare sacrifici a Yhwh. Troppo grande è stata l’esperienza della sua guarigione.