Commento al Vangelo
Domenica 21 settembre, commento di don Renato De Zan
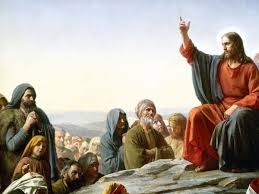
Lc 16,1-13
In quel tempo, Gesù 1 diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 2 Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 3 L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. 4 So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 5 Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 6 Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. 7 Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 8 Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 9 Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 10 Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 11 Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? 12 E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 13 Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».
Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze (Colletta propria)
Testo
1. La formula liturgica del vangelo, Lc 16,1-13 (forma breve: Lc 16,10-13), è uguale alla pericope biblica corrispondente. In più c’è solo il classico incipit liturgico “In quel tempo, Gesù…”. Bisogna tuttavia notare che la liturgia ha voluto unire due brani letterariamente distinti. Il primo è Lc 16,1-8. Narra la parabola dell’amministratore disonesto e si chiude con una specie di proverbio: “I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce”. Il secondo brano, Lc 16,9-13, affronta il tema del buon uso dei beni e della scelta di gestirli non secondo la logica di “mamonà”, ma secondo la logica di Dio.
2. Il testo della formula, a livello narrativo, si può suddividere in tre parti. Nella prima, Lc 16,1-8a, viene narrata la parabola dell’amministratore disonesto. La seconda parte, Lc 16,8b, è costituita dalla conclusione sulla scaltrezza: maggiore nei figli di questo mondo, minore nei figli della luce. Lc 16,9-13 costituisce la terza parte cadenzata in tre momenti sapienziali. Nel primo, Gesù suggerisce l’elemosina (“fatevi degli amici con la ricchezza disonesta”). Nel secondo, il Maestro enuncia un principio semplice, ma chiaro: “Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti”. Poi, lo applica alla gestione delle ricchezze terrene, valutate come “cose di poco conto”. Nel terzo momento sapienziale, il Signore, enuncia un detto proverbiale, ma molto efficace: “Nessun servitore può servire due padroni”. O Dio o mamonà (tradotto in italiano con “ricchezze”.
Esegesi
1. La lettura della formula evangelica è ampiamente condizionata dalla prima lettura (Am 8,4-7). Si tratta di un testo profetico che, con tratti brevi ed incisivi, dipinge la logica di chi si è lasciato assorbire dalle ricchezze. Il ricco usa, per guadagnare di più, pesi falsificati, approfitta del bisogno del prossimo per strozzare i prezzi, smercia mercanzia di infimo valore come merce di buona qualità. Oggi come allora. Il giudizio di Dio, però, è uguale: “Certo non dimenticherò mai le loro opere”. Si tratta di una condanna senza appello nei confronti di questi comportamenti dettati dalla logica del denaro.
2. La parabola dell’amministratore disonesto evidenzia un dato importante: di fronte alle difficoltà bisogna saper reagire. L’amministratore, che comunque resta disonesto per il suo comportamento pregresso e per il suo comportamento illustrato dalla parabola stessa, viene lodato perché ha agito con scaltrezza” (in greco “fronimòs”, “con sagacia, con avvedutezza”). Nella difficoltà, dunque, bisogna darsi da fare e non bisogna arrendersi. L’amministratore disonesto ha dimostrato la capacità di reagire. Così dovrebbe fare il discepolo di Gesù. Il Maestro, tuttavia, conosce la difficoltà dei buoni nell’adoperare questa scaltrezza per il bene (“I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce”).
3. L’insegnamento successivo di Gesù riguarda l’uso della ricchezza. Essa, per natura sua non è neutra. La ricchezza ha in sé il germe della “adikìa”, dell’ingiustizia. Ciò avviene o per la sua origine (ricchezza guadagnata disonestamente) o per la mentalità che la ricchezza spinge ad assumere o perché la ricchezza è comunque traditrice (non ti accompagna fino in fondo: si muore da soli). Se uno si lascia, dunque, assorbire dal fascino della ricchezza assume un atteggiamento di ingiustizia che si porterà dentro sia nelle piccole sia nelle grandi scelte. Non è possibile, infatti, che una persona sia giusta e ingiusta contemporaneamente. E nel Regno dei cieli non c’è posto per gli ingiusti. La conclusione che Gesù trae da questa terza parte è diventata proverbio: “Non potete servire Dio e mamonà (ricchezza, possedimenti, potere, ecc.)”.
