Commento al Vangelo
Domenica 27 luglio, commento di don Renato De Zan
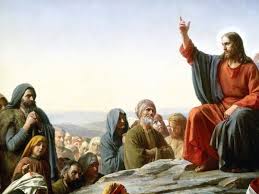
Lc 11,1-13
1 Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2 Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 3 dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 4 e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione». 5 Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 6 perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”, 7 e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, 8 vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 9 Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10 Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 11 Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 12 O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 13 Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
Signore, insegnaci a pregare
Testo
1. La formula liturgica del vangelo non ha subito nessun ritocco da parte della Liturgia. Bisogna, tuttavia, dire che la Liturgia ha accorpato – perché tematicamente uniformi – tre pericopi. La prima (Lc 11,1-4) comprende l’insegnamento del “Padre nostro”. La seconda (Lc 11,5-8) contiene un insegnamento sulla insistenza nella preghiera attraverso il racconto dell’amico che a mezzanotte va a chiedere tre pani. La terza pericope (Lc 11,9-13) riguarda ancora il tema della preghiera. L’aspetto particolare di questa pericope riguarda la confidenza e la fiducia dell’orante nei confronti del Padre.
2. Nel primo secolo la comunità cristiana aveva tre “Padre nostro”. Il più antico sembrerebbe essere quello riportato nella prima redazione della Didaché (ca. 70 d.C.), al capitolo VIII. Questo è quasi uguale a quello presente nel vangelo di Matteo (Mt 6,9-13) – che è quello che tutti quanti noi preghiamo -, ma con una glossa che Matteo non ha (“poiché tua è la potenza e la gloria nei secoli’. Così pregate tre volte al giorno”). Il “Padre nostro” riportato da Luca è leggermente diverso da quello riportato da Matteo sia per lunghezza, sia per vocabolario. Non ha le aggiunte matteane (“nostro che sei nei cieli”; “sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”; “ma liberaci dal male”), ha qualche variante diversa e il vocabolario è greco (Matteo mantiene ancora il vocabolario aramaico).
Esegesi
1. Gesù viene presentato come il modello di colui che prega. A questo Maestro orante i discepoli chiedono che insegni loro la preghiera distintiva del gruppo (il Battista lo aveva fatto come ogni buon rabbino). Il “Padre nostro”, dunque, è la preghiera distintiva del discepolo di Gesù, di ogni tempo e di ogni luogo. Ci sono alcune particolarità lucane che meritano una sottolineatura. L’orante chiede il perdono dei “peccati” (non dei “debiti”) perché il cristiano che proveniva dal paganesimo non poteva capire “il debito” (classico concetto ebraico dovuto all’alleanza non rispettata). Inoltre, la dicitura greco-ellenistica “e infatti” equivale al nostro “affinché”. Dunque, l’orante chiede il perdono di Dio per poterlo poi devolvere agli altri.
2. Ad un serio esame il testo del “Padre nostro” non si presenta come qualche cosa di originalissimo. All’epoca di Gesù, alla fine della “shachrit” sabbatica sinagogale (culto del mattino) l’assemblea concludeva l’incontro con il “Qaddish”: “Esaltato e santificato sia il suo grande nome nel mondo che egli creò secondo la sua volontà: domini il suo regno nel tempo della vostra vita e nei vostri giorni e durante la vita di tutta la casa d’Israele presto e in un tempo vicino”. Come si può notare le due preghiere, il “Qaddish” e il “Padre nostro”, condividono alcune tematiche importanti. Il “Padre nostro”, tuttavia è tutt’altra cosa.
3. Il testo evangelico associa la preghiera del “Padre nostro” all’insegnamento di Gesù sulla continuità e sulla perseveranza. Nel primo insegnamento, illustrato dalla parabola dell’amico che a mezzanotte va in cerca di tre pani presso l’altro amico, Gesù spinge verso l’insistenza nella preghiera (nel testo biblico si parla di “invadenza”: cf il v. 8). Nel secondo insegnamento Gesù evidenzia il primo obiettivo della preghiera, senza escluderne altri. L’obiettivo non è tanto ottenere questa o quella grazia, frutto di un modo nostro di vedere la vita. Si tratta invece di ottenere il dono dello Spirito il quale sa tradurre in preghiera al Padre ciò di cui abbiamo veramente bisogno, sostiene la fede del credente e gli dona i carismi, inabita in lui, garantendogli la risurrezione.
Contesto liturgico
1. Nella prima lettura (Gen 18,20-32) viene narrato l’episodio della preghiera di Abramo perché Dio, intenzionato a distruggere Sodoma, non uccida insieme ai peccatori i pochi giusti che vi abitano. Il dialogo orante di intercessione è commovente. Abramo parte ipotizzando la presenza di cinquanta giusti. Poi si rende conto che il numero è troppo elevato e, progressivamente, scende fino a dieci. E Dio gli promette che per rispetto anche di dieci giusti non distruggerà Sodoma. Ma quei dieci, purtroppo, non ci sono e Sodoma verrà distrutta.
2. La Colletta propria è stata tutta costruita sul brano evangelico. Nell’amplificazione si evidenzia come Gesù abbia insegnato ai suoi discepoli a chiamare Dio con il nome di “Padre” (probabilmente “papà”). Nella petizione, invece, si chiede che il Padre invii il suo Spirito, come Gesù ha insegnato.
