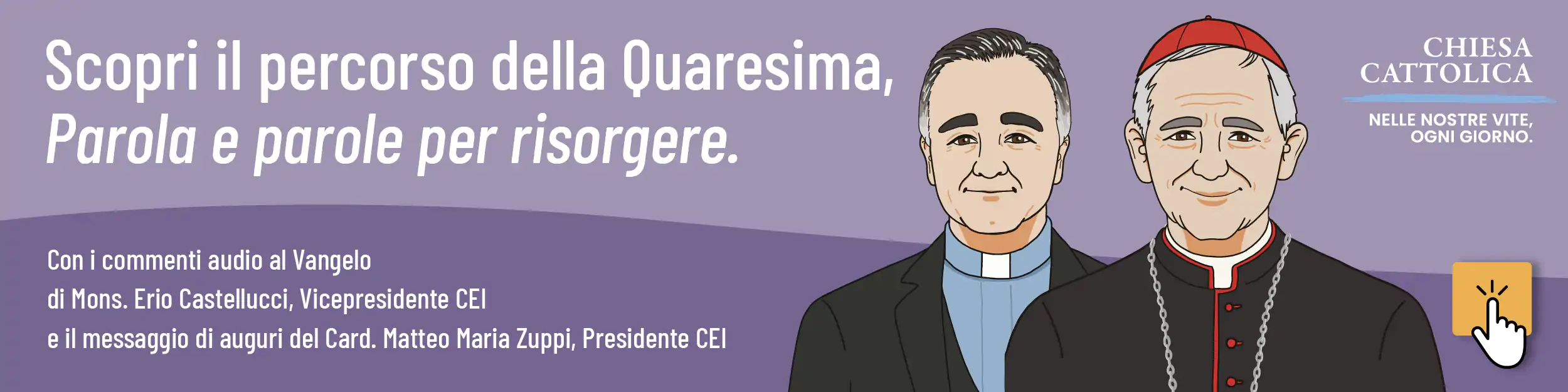Commento al Vangelo
Domenica 13 luglio, commento di don Renato De Zan

Lc10,25-37
In quel tempo, 25 un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28 Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 29 Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30 Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 37 Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
Il Testo
1. Il dottore della Legge che interroga Gesù è senz’altro della corrente farisaica. I farisei credevano nella vita oltre la vita e nella risurrezione. I sadducei non credevano a queste due verità di fede. è strano che un dottore della Legge chieda a Gesù cosa deve fare per ottenere la vita eterna. La Toràh conteneva – secondo un computo rabbinico – 613 leggi, osservando le quali si otteneva la vita eterna. La domanda del dottore della Legge è tendenziosa. L’evangelista, infatti, dice: “Si alzò per metterlo alla prova”.
2. La formula evangelica è stata leggermente modificata dalla Liturgia, che ha soppresso l’incipit originale (“Ed ecco”) sostituendolo con il generico incipit liturgico (In quel tempo”). Il brano si divide, a livello letterario, in tre parti. Una prima parte (Lc 10,25-29) contiene il dialogo iniziale tra il dottore della Legge e Gesù. Segue il racconto esemplare del buon Samaritano (Lc 10,30-35), chiamato popolarmente “parabola del buon Samaritano”. L’ultima parte (Lc 10,36-37) contiene il breve dialogo conclusivo tra Gesù e il dottore della Legge.
L’Esegesi
1. Tutto inizia con la domanda del dottore della Legge. La domanda dà luogo a una disputa rabbinica che si articola in un gioco letterario: il rabbino interrogato non risponde direttamente, ma pone, a sua volta, una domanda all’interrogante. Costui, rispondendo alla contro-domanda del rabbino, si dà anche la risposta da solo e il rabbino approva la auto-risposta corretta. Il dialogo sarebbe finito. Ma il dottore pone una seconda domanda (doveva pur mettere alla prova il rabbino di Nazaret).
2. Per il mondo ebraico il “prossimo” poteva essere solo un altro ebreo. Gli altri erano “stranieri”. Alla seconda domanda del dottore della Legge, Gesù risponde con un racconto perché, come si vedrà, il Maestro vuole andare oltre lo schema ebraico di “prossimo”. Nel racconto ci sono alcuni punti salienti da evidenziare. Il primo è che sia il sacerdote sia il levita sarebbero tenuti a occuparsi del mercante che giaceva ferito ai lati della strada. Non lo fanno perché a contatto con il ferito sarebbero diventati impuri, cioè inadatti a compiere il loro servizio liturgico nel tempio. Preferiscono l’osservanza della legge di purità all’attenzione del prossimo bisognoso. Il secondo punto è che il Samaritano è nemico giurato dell’Ebreo. Eppure costui passa accanto al ferito, ne prova compassione, si ferma, lo soccorre e lo porta a un albergo, pagando del denaro per l’assistenza del ferito. Al Samaritano non è importato diventare “impuro” (bisogna ricordarsi che anche i Samaritani hanno un Pentateuco quasi uguale a quello ebraico). È stato più importante dare spazio alla compassione per il prossimo bisognoso.
3. Il dialogo conclusivo sottintende la domanda del dottore della Legge (“Chi è il mio prossimo?”). Gesù pone una domanda, a prima vista ingenua, di fatto rivoluzionaria: “Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. È come se Gesù dicesse: “Non chiederti chi è il tuo prossimo, ma chiediti: tu prossimo di chi sei?”. In questo sta la rivoluzione cristiana. Il discepolo di Gesù non si pone la domanda: chi è il mio prossimo?, ma si chiede: io prossimo di chi sono? La risposta del dottore della Legge è ritenuta impeccabile da parte di Gesù che gli suggerisce: “Va’ e anche tu fa’ così”. Si tratta di una conclusione che illumina il racconto: è un esempio da imitare (abbi compassione verso tutti coloro che sono nel bisogno, anche verso il tuo nemico).
Il Contesto celebrativo
1. Nel fine della petizione della Colletta propria (“affinché, a immagine del tuo Figlio, ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza”) non c’è solo un richiamo all’opera sanatrice di Gesù, ma c’è anche un velato richiamo all’interpretazione che S. Agostino dà alla parabola. Il Buon Samaritano sarebbe Gesù che si preoccupa del peccatore (il mercante) ferito dai peccati (briganti). Lo carica sulla sua cavalcatura (lo accoglie nella sua umanità) e lo consegna al sacerdote (albergatore) perché nell’albergo (la Chiesa) lo curi con le due monete (i sacramenti dei vivi e dei morti) e al suo ritorno (Parusia) finirà di compiere la sua opera di compassione (la salvezza).
2. La prima lettura (Dt 30,10-14) offre il quadro entro il quale collocare l’insegnamento di Gesù. Il comando di Gesù (“Va’ e anche tu fa’ così”) “non è troppo alto per te, né troppo lontano da te…Questa parola… è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica”.