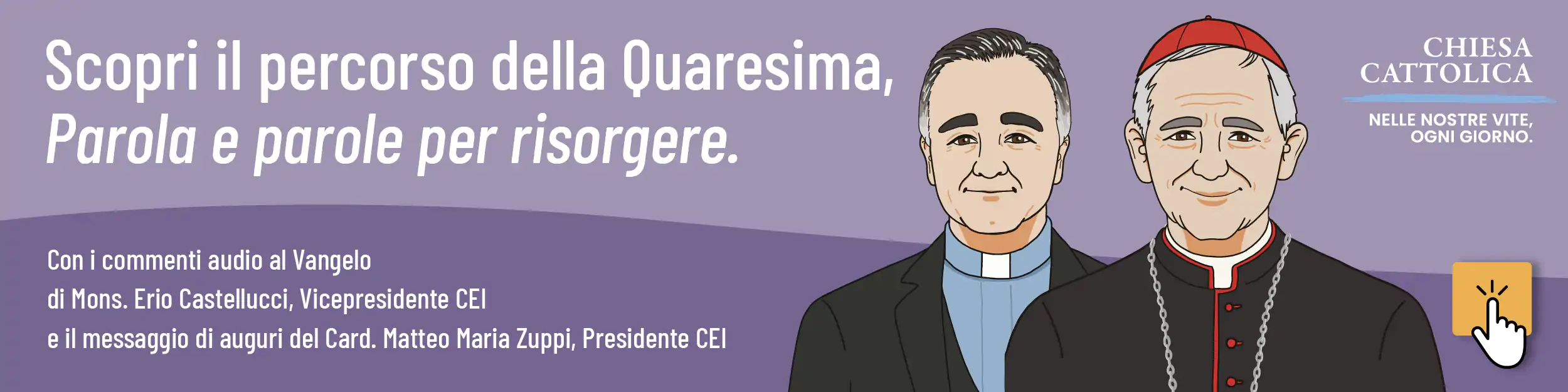Commento al Vangelo
Domenica 23 novembre, commento di don Renato De Zan

Lc 23,35-43
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, 35 Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 36 Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 37 e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38 Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40 L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 41 Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 42 E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». 43 Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Costui è il re dei Giudei
Il Testo
1. Il racconto della Passione, secondo Luca, comprende due capitoli, Lc 22,1-23,56. Di questo ampio testo, solo pochi versetti sono dedicati alla crocifissione e alla morte di Gesù, Lc 23,33-49: la crocifissione (Lc 23,33-34), gli oltraggi (Lc 23,35-38), il buon ladrone (Lc 23,39-43), la morte (Lc 23,44-46). Di questo materiale, la Liturgia si avvale solo di Lc 23,35-43, scegliendo di tralasciare la crocifissione e la morte del Signore. All’inizio del testo viene posto un corposo incipit: “In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù”.
2. La formula liturgica del vangelo (Lc 23,35-43) è scandito in quattro momenti narrativi. Il primo comprende la derisione del crocifisso da parte sia dei capi del popolo sia dei soldati (Lc 23,35-37). Il secondo momento contiene la derisione scritta di Erode impressa nel cartiglio che era posto sulla parte alta della croce (Lc 23,38). Il terzo narra l’atteggiamento del malfattore malvagio e quello del malfattore buono (Lc 23,39-42). Il quarto momento contiene la luminosa risposta di Gesù al malfattore buono (Lc 23,43).
L’Esegesi
1. La derisione degli uomini nei confronti di Gesù crocifisso è disposta in modo concentrico (a-b-b’-a’: Cristo – re – re – Cristo). I capi dicono al crocifisso di salvarsi perché egli era “il Cristo” (/a/). I soldati ripetono l’invito a salvarsi perché egli era “il re dei Giudei” (/b/). Lo stesso si trova nel cartiglio: Gesù è “il re dei Giudei” (/b’/). Il Malfattore cattivo rinnova l’invito a salvarsi (e a salvare i malfattori) poiché egli è “il Cristo” (/a’/). L’irrisione oscilla tra il religioso (“il Cristo”) e il politico (“il re dei Giudei”). Gesù, infatti, aveva deluso sia le aspettative religiose perché non era il Messia che gli Ebrei di allora si aspettavano. Aveva deluso anche le attese politiche perché non era stato il condottiero liberatore.
2. L’inno cristologico che si trova all’inizio della lettera ai Colossesi (2° lettura: Col 1,12-20), testo della Chiesa nascente e di parecchio precedente la lettera che lo ospita, afferma che il Padre “ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati”. Questi brevi stichi illustrano in breve come dietro alla beffa ci sia la verità: Gesù, per davvero, è re dell’Universo. La regalità del Maestro non si misura sulla potenza umana (cf Gv 18,36: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”).
3. Di fronte a Pilato Gesù stesso aveva detto di sé: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” (Gv 18,37). Sappiamo che sotto il profilo biblico “la verità” indica, detto in sintesi e semplificando, la fedeltà di Dio nei confronti dell’uomo. La regalità di Gesù è la manifestazione di questa fedeltà di Dio nei confronti dell’uomo. L’intervento del malfattore buono, per antitesi con tutti gli altri, pone in evidenza il valore della realtà nei confronti dei giudizi nati da una valutazione superficiale, fondata sulla pura apparenza. Solo questo malfattore intuisce l’innocenza di Gesù (“egli invece non ha fatto nulla di male”) e la sua regalità (“ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno”), come fedeltà all’uomo.
4. In modo sobrio e chiaro, l’affermazione del buon ladrone rileva come Gesù, autoproclamandosi re, ha detto il vero. E poiché ciò che è vero è giusto, il buon ladrone, come controprova della sua riflessione, si rivolge a Gesù, chiedendogli di ricordarsi di lui, uomo dall’umanità povera e ferita, quando sarà nel Regno. La risposta di Gesù è stupefacente: “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. Qualcuno ha voluto deturpare la frase di Gesù, riproponendola così: “In verità io ti dico oggi: con me sarai nel paradiso”. In tutte le edizioni critiche del testo greco del Nuovo Testamento “oggi” viene associato non a “io ti dico”, bensì a “con me sarai in paradiso”.
Contesto Celebrativo
1. Sappiamo che il Regno, in ambito neotestamentario, privilegia il significato di “signoria”. Cristo è re in quanto esercita una signoria nel creato, venuto all’esistenza per mezzo di Lui. Esercita la stessa signoria nella storia, che Egli guida verso il punto omega o il compimento, e negli uomini (non sugli uomini), che da Lui sono salvati. Per i credenti, Gesù è re perché è “il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti”. Tale ruolo, da dove gli viene? La prima lettura indica un elemento della regalità di Gesù. Egli è Figlio di Davide e quindi di discendenza regale e messianica (cf prima lettura: 2Sam 5,1-3 : unzione regale di Davide).
2. Un secondo elemento della regalità di Gesù si colloca nella sua passione e morte salvifiche. Il Signore è re perché ha adempiuto fino in fondo la volontà del Padre e, quale Servo di Yhwh, ha donato tutto se stesso per la salvezza dell’umanità. In Gesù, la “signoria” di Dio è stata totale. Il discepolo di Gesù, che è chiamato a imitare il Maestro, avrà in sé la “signoria” di Dio. È il Regno. La Colletta propria fa diventare preghiera questa verità di fede: “O Padre, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell’amore,…seguendo le orme di tuo Figlio, possiamo condividere la sua gloria…”.