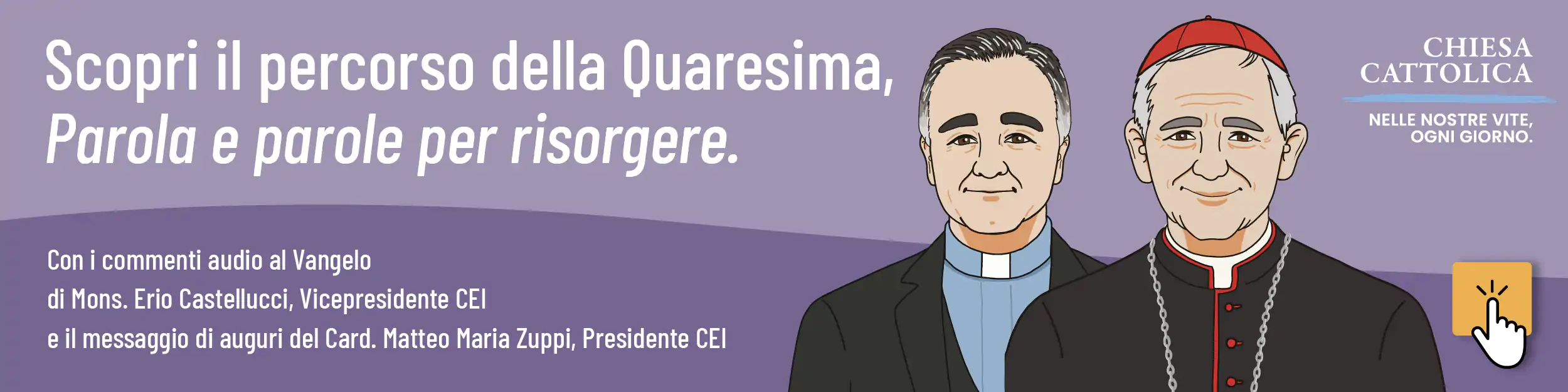Commento al Vangelo
Domenica 7 settembre, commento di don Renato De Zan
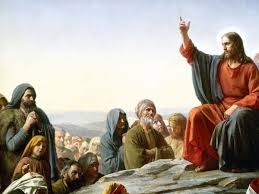
Lc 14,25-33
In quel tempo, 25 una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 26 «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 27 Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. 28 Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 29 Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, 30 dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 31 Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 32 Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. 33 Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
Il Testo
- La pericope originale comprende Lc 14,25-35. Contiene tre testi non separabili: rinuncia a quanto ci è caro (Lc 14,25-27); rinuncia ai propri averi (Lc 14,28-33); perseveranti nella propria identità (Lc 14,34-35). La Liturgia ha preferito tagliare i vv. 34-35 (“Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti”), probabilmente per mettere in evidenza il ritornello “non può essere mio discepolo” (Lc 14,26.27.33), facendolo diventare, nella formula evangelica, un’inclusione nell’intervento di Gesù (Lc 14,25-33). La Liturgia, poi, modifica l’incipit. Quello originale diceva: “Una folla numerosa andava con lui”: Il nuovo incipit recita così: “In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù”.
- La formula liturgica del vangelo, Lc 14,25-33, può essere divisa in quattro parti narrative. La prima (Lc 14,25) presenta la scena: Gesù si rivolge alla folla numerosa. Seguono poi tre parti tra loro legate dallo schema concentrico. Nel segmento /a/ troviamo l’espressione “non può essere mio discepolo” ripetuta due volte (Lc 14,126.27). Nel segmento /b/ ci sono due “meshalim” che potremmo chiamare approssimativamente “esempi”: la costruzione della torre e la partenza per la guerra (Lc 14,28-32). Infine, il segmento /a’/ che riprende l’espressione “non può essere mio discepolo”.
L’Esegesi
- Nel segmento /a/ c’è un problema da risolvere: riguarda il linguaggio biblico per il quale è come se tutto fosse diviso in due parti: non c’è la terza via e non c’è sfumatura. O si ama o si odia. Si veda il detto di Gesù in Lc 16,13: “Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona”. In occidente, invece, siamo molto più sfumati: tra amare e odiare c’è posto per il voler bene, la simpatia, l’indifferenza, l’antipatia…Nel testo originale di Luca, in greco, troviamo scritto: “Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita…”. Matteo ha capito l’impatto negativo di tale linguaggio e lo traduce così: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me” (Mt 10,37). Per questo motivo i traduttori in Lc 14,26 hanno reso il testo originale in questo modo: “Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo”. Traduzione letterale sbagliata, ma traduzione concettuale perfetta.
- Sempre nel segmento /a/ troviamo due espressioni classiche: “prendere la croce” e “venire dietro a me”. Su ambedue già più volte è stato spiegato il valore. La prima indica la capacità di restare soli e incompresi – come Gesù nel momento della salita al Calvario – a causa della propria fede. La seconda designa la decisione di impostare tutta la propria vita nell’imitazione del Maestro. Gesù ha voluto dire che il legame con lui non può essere impedito da quelle forme non sempre armoniche di amore verso i propri cari. Il sano rapporto con Dio rende sani tutti gli altri legami. Inoltre, la morale del discepolo non è fatta di principi, ma di imitazione. Paolo, infatti, ripeteva: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20) oppure “Per me infatti il vivere è Cristo” (Fil 1,21).
- Nel terzo segmento /a’/ ricompare la durezza del linguaggio: “Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi…” (Lc 14,33). Sui beni di questo mondo, il discorso è già stato fatto molte volte da Luca. I beni non devono ridurre in schiavitù l’uomo, ma l’uomo è giusto che se ne serva. Ciò rende l’uomo distaccato e capace di condivisione. Il linguaggio appare un po’ più “occidentale” in Lc 16,9: “Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand’essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne”.
- Nei segmenti /a/ e /a’/ troviamo le tre condizioni che il discepolo è tenuto ad osservare. Senza l’adesione a queste condizioni nessuna persona può essere discepolo di Gesù. La prima condizione consiste nel riconoscere che l’amore verso Gesù (Dio) è superiore ad ogni altro amore, sebbene umanissimo e nobile. La seconda condizione riguarda l’accoglienza della croce per imitare Gesù e condividere con lui il cammino verso l’adempimento della volontà di Dio. La terza condizione tocca la capacità di essere distaccati dai propri beni fino alla rinuncia, se necessario. I “meshalim” invitano a non sottovalutare l’impegno necessario per essere discepoli di Gesù.
Il Contesto celebrativo
I veri valori ce li può comunicare solo Gesù Cristo. E’ giusto, infatti, ricordare l’ammonimento della prima lettura (Sap 9,13-18b): “A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi può rintracciare le cose del cielo?”. La Colletta propria tralascia le tre condizioni poste da Gesù e sottolinea solo l’accoglienza della propria croce. Si veda quanto invoca nella petizione: “Donaci la sapienza del tuo Spirito, perché da veri discepoli portiamo la nostra croce ogni giorno dietro il Cristo tuo Figlio”.