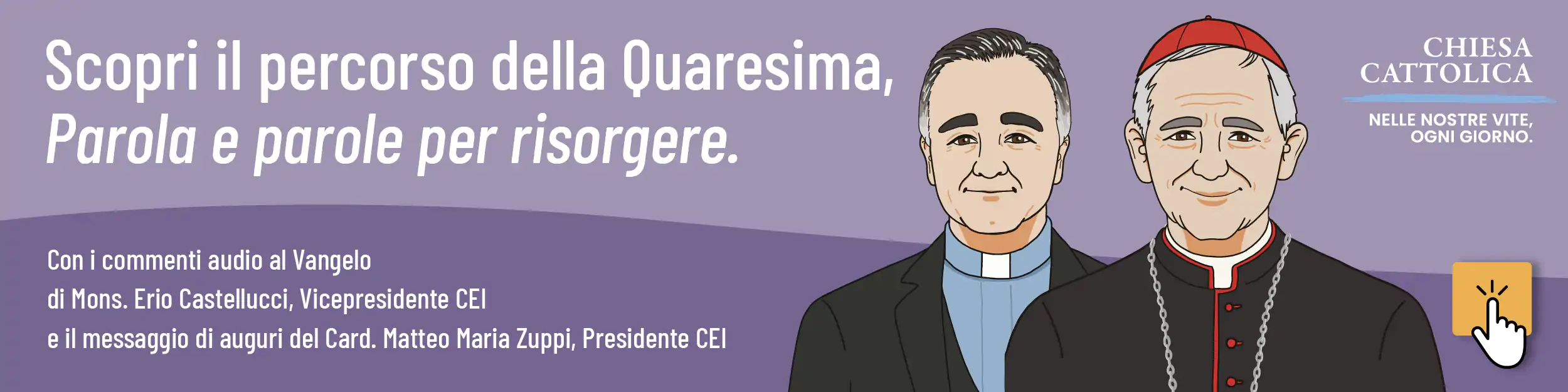Commento al Vangelo
Domenica 30 marzo, commento di don Renato De Zan

Tu 4° di Quaresima – C (21.03.2004)
Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita
Lc 15,1-3.11-32
In quel tempo, 1 si avvicinavano a lui a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2 I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 3 Ed egli disse loro questa parabola: 11 Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13 Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17 Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19 non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. 20 Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. 22 Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 23 Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26 chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27 Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 28 Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29 Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 31 Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
Il Testo
1. Secondo molti biblisti, il testo eclogadico di Lc 15,1-3.11-32 rappresenterebbe il testo della prima stesura del vangelo di Luca. Prima della pubblicazione l’evangelista avrebbe aggiunto Lc 15,4-10 (il paragone della pecora perduta e ritrovata e quello della moneta perduta e ritrovata) per una ragione interpretativa. I due paragoni, infatti, accompagnano il lettore verso una lettura sfumatamente allegorica: il pastore e la donna rappresenterebbero Dio. In questo modo diventa facile – senza andare oltre nell’allegoria – identificare il padre della parabola con Dio. Lo stadio arcaico del vangelo, però non permetterebbe questa leggera allegorizzazione.
2. La formula liturgica, letta nella celebrazione, è stata ritoccata dalla Liturgia. Sono state cancellate – oltre a Lc 15,4-10 – due espressioni: al v. 1 “a lui” sostituita con l’esplicitazione “a Gesù” e al v. 11 l’espressione “Disse ancora”. Inoltre è stato aggiunto il solito incipit “In quel tempo”. Questi ritocchi fanno scorrere bene la lettura del testo. La formula si divide in due parti. Nella prima, Lc 15,1-3, troviamo narrato l’antefatto (scribi e farisei rimproverano Gesù di accogliere tutti i peccatori e i pubblicani e mangiare con loro). Nella seconda, Lc 15,11-32, viene presentata la parabola. Ricordiamo che la parabola è sempre un fatto vero o verisimile. Presenta una situazione che l’ascoltatore è chiamato a giudicare. Il giudizio ricade sull’ascoltatore stesso perché la situazione narrata dalla parabola è la stessa vissuta dall’ascoltatore. La parabola vera è sempre una dura provocazione con la quale il mittente obbliga l’ascoltatore a giudicare se stesso.
L’Esegesi
1. La provocazione degli scribi e dei farisei era già avvenuta in Lc 5,29-32 con la stessa accusa. Gesù rispose: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano”. Perché evidenziare nuovamente la stessa accusa? In Lc 15,11-32 Gesù vuole sanamente provocare gli scribi e i farisei. Se un figlio sbaglia, si accorge dell’errore, si converte, come va accolto? Come il padre che offre al figlio una seconda possibilità? Oppure come il fratello maggiore che inchioda il fratello minore alle sue malefatte, senza tener conto della sua conversione e senza dargli una seconda opportunità? Se una persona non si lascia prendere dall’istinto di vendetta, ma riflette saggiamente da buon educatore, deve dar ragione al padre e non al fratello maggiore. Ma tu – scriba o fariseo – se dai ragione al padre, come puoi rimproverare Gesù che si comporta come il padre?
2. La parabola è articolata in quattro momenti principali. Nel primo, Lc 15,11b-13a, c’è l’avvenimento presupposto (il figlio ottiene dal padre le sostanze che gli spettano e parte). In Lc 15,13b-19 viene descritta la disgraziata avventura del figlio più giovane: prima sperpera in dissolutezze il patrimonio ricevuto, poi si mette a servizio di uno straniero (l’ebreo non può farlo!) e pascola i porci (l’ebreo non può farlo perché sono animali impuri!). “Ritorna in sé” (il testo greco indica un cammino d’introspezione), capisce e mette in piedi una recita perfetta per essere riaccettato dal padre. Successivamente (Lc 15,20-24), torna dal padre, che gli corre incontro, lo abbraccia e lo bacia (segni di totale riconciliazione) e non gli permette di completare la recita. Ordina che venga dato al figlio il vestito più bello (segno della riacquistata dignità), gli dona l’anello (il figlio viene reintegrato nella sua identità di figlio e nella sua capacità di ereditare ancora) e i sandali (segno della posizione di uomo libero). Poi ordina l’uccisione del vitello grasso (= grande festa) per mangiare insieme e fare festa. In Lc 15,25-32 vien descritta la reazione del fratello maggiore, dura e astiosa, e l’intervento saggio (e ironico) del padre: “Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio e tuo (non avevi bisogno di nessun permesso per prenderti il capretto!)”. Il figlio minore è tornato: è necessario (in greco “dèi”: è il verbo dell’obbligo imprescindibile) fare festa e rallegrarsi.
Il Contesto Liturgico
Alle origini del popolo ebraico il Signore allontanò da loro “l’infamia di Egitto” (1a lettura: Gs 5,9a), cioè la schiavitù. Nei tempi nuovi Dio ha riconciliato a sé “il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando” agli apostoli “la parola della riconciliazione” (1a lettura: 2Cor 5,19). La Liturgia, in questa domenica chiamata “Dominica Laetare”, vuole celebrare la riconciliazione di Dio con gli uomini, nella serenità e nella gioia. Questo è il messaggio dell’Antico Testamento (cf Sal 51,10a.14a: “Fammi sentire gioia e letizia…. Rendimi la gioia di essere salvato…”), che viene ripreso e ampliato nel Nuovo (Lc 15,32: “Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”).